Posted: Ottobre 21st, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: carcere, gaza, human rights watch, IDF, immigrazione, intifada, ketsiot, prigionieri palestinesi | Commenti disabilitati su Ketsiot, no way out
1993, 6 novembre – Il primo numero del settimanale Internazionale raccoglie nella sua magra cinquantina di pagine il “racconto di una giornalista israeliana sulla vita dei palestinesi nel peggiore campo di detenzione di Israele”. L’intifada in prigione di Ada Ushpiz, tre facciate nero su bianco, sei colonne in tutto, nessuna immagine – non che ve ne sia una stretta necessità: si tratta di uno di quei (meravigliosi) casi in cui le parole si srotolano nella nostra mente una dopo l’altra supplendo all’aspetto visivo, permettendoci di assistere alla scena narrata, fotogramma dopo fotogramma.
Ogni detenuto dorme su delle tavole di legno; la distanza fra le tavole che compongono il “letto” causa un forte dolore alla schiena. I materassi sono vecchi, maleodoranti. Le coperte sono piene di buchi e non esistono cuscini. Ogni tenda è illuminata con due lampadine da 25 watt, che non permettono la lettura notturna. I secchi della spazzatura sono scoperti, attirando zanzare e altri insetti. Nei bagni non c’è luce; ci sono insetti, serpenti, topi e scorpioni. I pasti sono sempre uguali, insufficienti per quantità e per qualità. I detenuti non sanno cosa gli è consentito per legge e quando chiedono miglioramenti nell’alimentazione gli viene risposto sempre che “questa è la legge”. Così nascono le malattie; spesso i detenuti devono protestare con lo sciopero della fame per ottenere di essere curati. A ciò si aggiungono sistemi disumani per far pressione sui malati, per fargli tradire il loro popolo e la loro patria. […] I bambini non possono toccare il padre o il fratello, il padre non può abbracciare i propri figli. In breve, le condizioni di vita nel carcere di Ketsiot non sono adatte agli esseri umani.
Si inserisca il tutto in un clima di umiliazione, violenza, divieto di visita da parte dei parenti, negazione del diritto di parola e di informazione. Ecco il campo di Ketsiot, situato nel deserto a sud di Gaza sul confine egiziano, nel 1993. L’articolo dimostra una (alquanto velata) speranza, riportando come in questo “periodo di nascita della pace” (si sono da poco conclusi gli accordi di Oslo) si sia aperto un dibattito, se non sullo smantellamento, almeno sul miglioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere. (Anche se qualche rigo dopo si manifesta un’evidente perplessità circa l’attuazione di queste misure.) Ma facciamo prima un passo indietro.

1991 – Che Ketsiot sia il peggiore campo di detenzione in Israele era già stato esposto dal rapporto di Eric Goldstein per Human Rights Watch: la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra, la quale proibisce il trasferimento delle persone incarcerate dai territori occupati ai territori del potere occupante. Inoltre, la pari distanza del sito da Gaza e dalla West Bank rende difficilmente raggiungibile l’area da parte di familiari e legali (ricordate il problema di muri e checkpoint vari e aggiungetevi la necessità di una richiesta scritta che i palestinesi devono presentare all’IDF per poter visitare i parenti in carcere). Ancora: Ketsiot è un deserto, con tutte le complicazioni atmosferiche che questo può avere (tempeste di sabbia, escursione termica da 0 gradi al caldo torrido, due o tre giorni senz’acqua), e i detenuti “vivono” in tende, le condizioni climatiche delle quali non possono essere attenuate. Il tono dell’intero rapporto si mantiene altamente oggettivo, al punto di essere quasi scambiato per cinico: è, quindi, proprio per questo significativo che arrivi ad affermare: “il campo di Ketsiot infligge ai suoi detenuti un regime di isolamento e violenza che va ben oltre l’essere semplicemente incarcerati”.
Leggendo che “la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra” ho (ingenuamente) pensato: “Finalmente qualcuno, impugnando questa Convenzione, farà qualcosa!”. Ma, dal momento che la Convenzione si pone “as conventional rather than customary law”, le sue disposizioni non possono essere fatte rispettare dalla corte israeliana, poiché non incorporate nella legge nazionale. Cioè: tutte le mozioni contro la legalità di Ketsiot vengono puntualmente respinte. Deduco, quindi, che non godano di ampio spessore le UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners che ritengono illegali l’utilizzo di manette per un periodo prolungato (a Ketsiot, questo avviene talvolta per giorni e giorni, bloccando mani e piedi) o il ricorso a celle di isolamento (le celle di Ketsiot sono della grandezza di 3 metri quadrati e ospitano una media di 5/6 detenuti per una decina di giorni).

Con la guerra del Golfo, si inaspriscono le condizioni di vita. Con l’insistenza delle pressioni internazionali, il numero dei detenuti cala. Ma il loro stato peggiora. Così, il campo carcerario istituito dal governo Rabin a seguito della prima intifada – per raccogliere 5000 tra lanciatori di pietre, attivisti e leader, ossia l’intellighenzia palestinese, secondo un disegno che indebolisse e contrastasse l’intifada stessa – e che, una volta superata la situazione d’emergenza, avrebbe dovuto essere smantellato, non ha esaurito la sua funzione. Anzi.
Nel 2002, i detenuti protestano denunciando l’assenza di acqua calda e di elettricità costante, il sovraffollamento e il divieto di visite da parte dei familiari. Gli scontri portano a 16 feriti: 14 tra i detenuti, 2 tra le forze dell’ordine. Nel 2003, si avvia un progetto per raddoppiare la capacità di Ketsiot così da rendere il campo capace di accogliere 12·000 detenuti, rispondendo alla politica di arresti su larga scala, per i quali si portano in carcere 15 palestinesi ogni giorno.
2012 – Viene approvato un ulteriore progetto per rendere Ketsiot atto a contenere 16·000 detenuti. Ma c’è una novità: la maggior parte dei detenuti è rappresentata da immigrati, principalmente originari di Eritrea e Sudan, arrivati per richiedere asilo allo stato di Israele, il quale né esamina le loro richieste, né concede loro alcun diritto, proteggendoli unicamente dalla deportazione. La prassi è quella di incarcerare gli immigrati per un periodo minimo di tre anni, prolungabile ad libitum. Ciò implica, ad esempio, che a Ketsiot bambini nascano e crescano, senza conoscere il significato della parola fuori. Ad esempio.
Non hanno diritti, detenzione eterna per tutti. [..] A meno che non si possa deportarli, non resta altro da fare che incarcerarli e rendere le loro vite miserabili.
Il ruolo di legali e giudici si limita a informare i detenuti dell’impossibilità di modificare la loro situazione, i quali devono, dunque, accettare la loro situazione. Il titolo di un articolo mi sembra particolarmente efficacie per sintetizzare questo quadro: “Una prigione per richiedenti asilo nel deserto cocente, senza via d’uscita”. No way out.
Alcuni aspetti, dunque, permangono: le condizioni di vita dei carcerati, siano essi palestinesi o sudanesi o eritrei, si pongono ad un livello infimo e la carcerazione avviene senza processo e/o senza accusa. Inoltre, ieri come oggi, il carcere non ha alcun risultato deterrente nei confronti della rivoluzione prima, dell’immigrazione poi; non ha, quindi, un riscontro effettivo a livello di sicurezza interna. Il ruolo primario degli arresti, della detenzione a vita, delle condizioni umilianti, è unicamente di “saziare l’opinione pubblica”. Ma davvero? Pazzesco.
Per chiudere il parallelismo tra queste due condizioni, mi sembra illuminante la riflessione di Joseph Carens:
La cittadinanza nell’occidente è oggi assimilabile ai privilegi feudali di un tempo, ossia uno status ereditario che aumenta le possibilità di sopravvivenza del singolo. Per coloro che non nascano con tale status è praticamente impossibile acquisirlo. Come per i privilegi feudali ereditari, questo risulta difficilmente giustificabile.

Posted: Ottobre 12th, 2013 | Author: Neno | Filed under: General, Recensioni, Rifiuti Generici | Tags: antifa, colonialismo, fabei, fascismo, lotte sociali, orbene, orientalismo, palestina | Commenti disabilitati su Antifascismo e Palestina. Appunti per un dibattito
Nella lunga serie di precisazioni “teoriche” da fare, e a mo’ di postilla all’ultimo capitolo del nostro “compendio” di storia palestinese, è forse opportuno aggiungere un distinguo di carattere prettamente politico al nostro discorso. È comunemente dato per scontato che la vicinanza ai palestinesi nell’ambito della “questione meridionale” sia una costante di sinistra. Orbene, facendo zapping cibernetico potrebbe esservi capitato di imbattervi in pagine come questa (ne ho scelta una a caso). Se aveste pazienza e stomaco a sufficienza, potreste trovarne molte altre simili. E dunque sì, i fascisti si dichiarano filopalestinesi.

Stefano Fabei (dx) e, a sx, Benito Mussolini (il dubbio era legittimo)
Svastiche e mezzelune. L’origine della propaganda filopalestinese da parte nazifascista risale agli anni ’30, quando entrambi i paesi dell’Asse avevano allacciato contatti con molte forze nazionaliste arabe per finanziare una guerriglia contro la Gran Bretagna mandataria. Di questi rapporti l’unica ricostruzione storica, almeno italiana, pare essere quella di Stefano Fabei. Il fascio, la svastica e la mezzaluna (Mursia, 2002) rappresenta effettivamente il primo tentativo di una narrazione unitaria del sostegno dei nazifascisti al nazionalismo arabo, ma in una maniera talmente acritica e decontestualizzata da far pensare che l’autore abbia effettivamente voluto sostenere una lettura di destra non solo della situazione palestinese, ma dell’intero Islam (!). Ad esempio, riguardo al rapporto tra la Germania nazista e il sionismo, Fabei pare non considerare determinante l’effetto delle persecuzioni antisemite sull’immigrazione verso la Palestina, accennando di sfuggita ai piani per “liberarsi degli ebrei” facendoli espatriare verso il Medio Oriente, sottolineando anzi (con soddisfazione, si direbbe) come il regime di Hitler concedesse agli arabi di usare i bagni pubblici interdetti ai “giudei”. Ma il lato più inquietante del saggio è il peso dato a certe interpretazioni piuttosto imbarazzanti che tentano di dimostrare una presunta affinità tra la visione politica arabo-islamica (ma araba o islamica? Di quali movimenti? Di quali strati sociali? Parliamo, per l’epoca, di ottanta milioni di arabi e di circa trecento milioni di musulmani) e quella nazifascista. Proprio la vaghezza di questi riferimenti permette a Fabei di evitare pressoché ogni riferimento alle finalità politiche (piuttosto evidenti) di un discorso del genere. In questa storia, gli stessi paesi arabi rimangono in secondo piano, e si dà quasi fin da subito per scontata la “simpatia araba per le forze dell’Asse”.

Antifascismo e Palestina. Un’opera del genere può lasciare ad un livello superficiale l’analisi dei rapporti storici tra fascismi e indipendentismo palestinese, ma mostra certo piuttosto bene l’atteggiamento odierno delle destre nei confronti della Palestina. La narrazione fascista della Palestina riprende quella tipicamente nazionalista del popolo che lotta contro l’invasore straniero per l’indipendenza. Il popolo è ovviamente considerato un blocco omogeneo non meglio determinato, che si immagina tenuto insieme da un impasto religioso-culturale costruito per l’occasione. Ma questo discorso tagliante e semplificante è già quello di chi guarda da fuori ma soprattutto da una posizione dominante. E’ l’orientalismo di cui fa un’ampia critica Edward Said, lo stesso che si fondava sul colonialismo europeo (e in cui a sua volta il colonialismo trovava una solida base). Si può scrivere una storia che riguardi i rapporti tra fascismi e paesi arabi senza che l’analisi passi per questi ultimi solo se si considera puramente teorico l’approccio da tenere verso le realtà extraeuropee (o extraoccidentali). Gli zoologi possono scrivere libri e libri per interpretare il comportamento di un animale, ma nessuno si sogna di chiedere all’animale stesso di intervenire nella loro stesura. E non si tratta affatto di un frame marginale o minoritario: è anzi la via retorica principale per ammantare di umanitarismo idee razziste o colonialiste, per sfociare spesso nel terrificante “aiutiamoli a casa loro” (“nutriamoli nelle loro gabbie” dice lo zoologo pieno di amore per gli animali che studia).
Come evitarlo? Non è una questione semplice. Forse fondamentale è cercare di non perdere di vista l’universalità della questione mediorientale. La lotta dei palestinesi contro lo sfruttamento, l’occupazione della terra e dell’acqua, la militarizzazione, l’opportunismo internazionale è la stessa lotta che combattiamo (dovremmo combattere?) anche qui. E non in senso metaforico. Si tratta di opporsi ad un sistema politico-economico che è lo stesso tra i checkpoint in Cisgiordania e nel cantiere della TAV, nell’apartheid arabo in Israele e nella schiavitù dei braccianti di Rosarno (e si potrebbe andare avanti, ovviamente). L’ideologia imperialista dei fascisti e della destra israeliana non è per nulla distante da quella dei “nostri” governi “occidentali”, che poi sono direttamente coinvolti nel sostegno alla colonizzazione della Palestina. Solo in quest’ottica la storia, le storie palestinesi possono diventare anche simboliche, e aiutarci a capire la nostra stessa realtà. Raccontarle senza perdere di vista la loro specificità e la loro complessità è quello che ci proponiamo fare.

Posted: Ottobre 4th, 2013 | Author: Neno | Filed under: General, Palestina per Principianti, Storia | Tags: anni trenta, colonialismo, haganah, irgun, mandato britannico, palestina, peel, spartizione, storia | Commenti disabilitati su Palestina negli anni Trenta. Dramma a tre voci.

Personaggi: Commissione Peel, arabi, ebrei, inglesi (nazisti, da qualche parte). Trama, conflitto a tre parti: gli arabi palestinesi combattono gli ebrei sionisti in cui vedono uno strumento degli inglesi colonialisti che combattono a loro volta; gli ebrei sionisti combattono gli inglesi colonialisti in cui vedono uno strumento degli arabi nazionalisti che combattono a loro volta; gli inglesi colonialisti reprimono tutto, ma si accorgono di non poterlo fare per sempre.
Anno domini: 1937, 1315 ca. dopo l’Egira musulmana. E’ nel periodo tra le due guerre mondiali che si trovano le radici più profonde del conflitto per la Palestina. Un conflitto annunciato (e ignorato), poi, una volta esploso, scomodo e spinoso per gli stati occidentali, inatteso e tragico per il medio oriente. Nel momento in cui assumeva il mandato sulla Palestina e dava appoggio alle richieste sioniste con la dichiarazione Balfour, la Gran Bretagna si trovava davanti una regione relativamente stabile e prospera, ma attraversata da profonde contraddizioni. I coloni sionisti erano circa trecentomila, e sarebbero andati aumentando dopo il ’33 per le persecuzioni nazifasciste (fatto che tra l’altro non impedì a Hitler e Mussolini di appoggiare alcuni movimenti nazionalisti arabi in funzione antiebraica e antbritannica). In breve tempo si erano appropriati (spesso comprandoli a pochissimo) di terreni sempre più estesi e decisamente fertili (e la terra fertile in Palestina non è infinita). Questa non sarebbe stata una novità nel mondo arabo, non fosse che i nuovi coloni parevano nettamente intenzionati a formare uno stato su quelle terre. Gli inglesi speravano comunque di riuscire a mantenere la stabilità (e il loro dominio coloniale).
Queste speranze furono alla prova dei fatti infondate poichè, nonostante la Palestina nel suo complesso fosse diventate più prospera, le cause delle rivolte del 1920 e ’21, segnatamente la richiesta da parte degli arabi di indipendenza nazionale e la loro opposizione al Focolare Nazionale [ebraico], sono rimaste immodificate e addirittura si sono accentuate per l’azione di “fattori esterni”, segnatamente la pressione degli Ebrei dell’Europa sulla Palestina, e lo sviluppo del nazionalismo arabo nei Paesi circostanti. (Dal testo del Rapporto presentato dalla Commissione Peel alle Nazioni Unite, come le citazioni seguenti; trad. mia)

La Commissione Peel (dal nome del funzionario britannico che la presiedeva) era stata creata per cercare una soluzione definitiva al conflitto, che dal 1935 aveva assunto proporzioni considerevoli con la “Grande Rivolta” araba, repressa violentemente dall’esercito inglese e resa ancor più sanguinosa dall’intervento delle milizie sioniste (Haganah e Irgun). Le svariate migliaia di vittime della repressione non potevano che rendere ancora più incandescente la situazione, posto che le stesse forze ebraiche si mostravano insofferenti alla presenza inglese. La Commissione inquadrava la situazione in una chiave semplice e netta: gli opposti nazionalismi arabo ed ebraico certo non lasciavano molte speranze alla Gran Bretagna di mantenere il controllo coloniale, ma parevano anche impedire qualsiasi forma di convivenza tra le altre due parti in gioco.
Il carattere del Focolare Ebraico è fortemente nazionalista. Non è nemmeno in questione la fusione o l’assimilazione tra le culture di Ebrei e Arabi. Il Focolare Nazionale non potrà essere semi-nazionale […] Il nazionalismo arabo è tanto intenso quanto quello ebraico. La richiesta dei leader arabi di autogoverno nazionale e di abbattimento del Focolare Nazionale Ebraico sono rimaste identiche al 1929.

D’altra parte era difficile che gli inglesi premessero troppo per una “assimilazione” che avrebbe rischiato di rivoltargli contro l’intera popolazione della regione su un unico fronte (per quanto quest’ipotesi fosse remota). Ma il divide et impera è un gioco pericoloso, specie quando le due parti divise hanno motivi uguali ed opposti per volerti distruggere prima di annientarsi tra loro. La Commissione Peel capì per prima che l’unico modo di salvaguardare la propria influenza, anche solo indiretta, era di dividere geopoliticamente l’area.
In queste circostanze la pace può essere mantenuta in Palestina sotto il Mandato [coloniale britannico] solo attraverso la repressione. Ciò implica il mantenimento di servizi di sicurezza ad un costo così alto che gli altri servizi, diretti “al benessere e allo sviluppo” della popolazione non potrebbero essere incrementati e anzi dovrebbero venire tagliati. […] L’idea della Partizione è stata senza dubbio pensata in un primo tempo come soluzione del problema, ma è stata probabilmente scartata perchè ritenuta impraticabile. Le difficoltà sono certo molto grandi, ma quando siano considerate da vicino, non paiono così insormontabili […] La Partizione offre possibilità di pace definitiva. Nessun altro piano lo fa.

Infatti il piano fu rifiutato dagli arabi insieme alla “pace definitiva” britannica, che suonava certo minacciosa. Nuove sollevazioni arabe avrebbero costretto gli inglesi a limitare l’immigrazione ebraica (con i tre Libri Bianchi), portando già durante e subito dopo il secondo conflitto mondiale, ad un esplosione del terrorismo sionista.











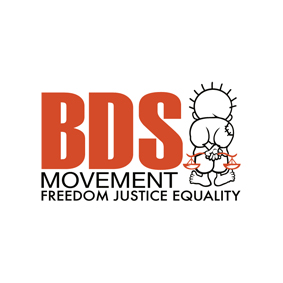


Commenti recenti