Ketsiot, no way out
Posted: Ottobre 21st, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: carcere, gaza, human rights watch, IDF, immigrazione, intifada, ketsiot, prigionieri palestinesi | Commenti disabilitati su Ketsiot, no way out1993, 6 novembre – Il primo numero del settimanale Internazionale raccoglie nella sua magra cinquantina di pagine il “racconto di una giornalista israeliana sulla vita dei palestinesi nel peggiore campo di detenzione di Israele”. L’intifada in prigione di Ada Ushpiz, tre facciate nero su bianco, sei colonne in tutto, nessuna immagine – non che ve ne sia una stretta necessità: si tratta di uno di quei (meravigliosi) casi in cui le parole si srotolano nella nostra mente una dopo l’altra supplendo all’aspetto visivo, permettendoci di assistere alla scena narrata, fotogramma dopo fotogramma.
Ogni detenuto dorme su delle tavole di legno; la distanza fra le tavole che compongono il “letto” causa un forte dolore alla schiena. I materassi sono vecchi, maleodoranti. Le coperte sono piene di buchi e non esistono cuscini. Ogni tenda è illuminata con due lampadine da 25 watt, che non permettono la lettura notturna. I secchi della spazzatura sono scoperti, attirando zanzare e altri insetti. Nei bagni non c’è luce; ci sono insetti, serpenti, topi e scorpioni. I pasti sono sempre uguali, insufficienti per quantità e per qualità. I detenuti non sanno cosa gli è consentito per legge e quando chiedono miglioramenti nell’alimentazione gli viene risposto sempre che “questa è la legge”. Così nascono le malattie; spesso i detenuti devono protestare con lo sciopero della fame per ottenere di essere curati. A ciò si aggiungono sistemi disumani per far pressione sui malati, per fargli tradire il loro popolo e la loro patria. […] I bambini non possono toccare il padre o il fratello, il padre non può abbracciare i propri figli. In breve, le condizioni di vita nel carcere di Ketsiot non sono adatte agli esseri umani.
Si inserisca il tutto in un clima di umiliazione, violenza, divieto di visita da parte dei parenti, negazione del diritto di parola e di informazione. Ecco il campo di Ketsiot, situato nel deserto a sud di Gaza sul confine egiziano, nel 1993. L’articolo dimostra una (alquanto velata) speranza, riportando come in questo “periodo di nascita della pace” (si sono da poco conclusi gli accordi di Oslo) si sia aperto un dibattito, se non sullo smantellamento, almeno sul miglioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere. (Anche se qualche rigo dopo si manifesta un’evidente perplessità circa l’attuazione di queste misure.) Ma facciamo prima un passo indietro.
1991 – Che Ketsiot sia il peggiore campo di detenzione in Israele era già stato esposto dal rapporto di Eric Goldstein per Human Rights Watch: la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra, la quale proibisce il trasferimento delle persone incarcerate dai territori occupati ai territori del potere occupante. Inoltre, la pari distanza del sito da Gaza e dalla West Bank rende difficilmente raggiungibile l’area da parte di familiari e legali (ricordate il problema di muri e checkpoint vari e aggiungetevi la necessità di una richiesta scritta che i palestinesi devono presentare all’IDF per poter visitare i parenti in carcere). Ancora: Ketsiot è un deserto, con tutte le complicazioni atmosferiche che questo può avere (tempeste di sabbia, escursione termica da 0 gradi al caldo torrido, due o tre giorni senz’acqua), e i detenuti “vivono” in tende, le condizioni climatiche delle quali non possono essere attenuate. Il tono dell’intero rapporto si mantiene altamente oggettivo, al punto di essere quasi scambiato per cinico: è, quindi, proprio per questo significativo che arrivi ad affermare: “il campo di Ketsiot infligge ai suoi detenuti un regime di isolamento e violenza che va ben oltre l’essere semplicemente incarcerati”.
Leggendo che “la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra” ho (ingenuamente) pensato: “Finalmente qualcuno, impugnando questa Convenzione, farà qualcosa!”. Ma, dal momento che la Convenzione si pone “as conventional rather than customary law”, le sue disposizioni non possono essere fatte rispettare dalla corte israeliana, poiché non incorporate nella legge nazionale. Cioè: tutte le mozioni contro la legalità di Ketsiot vengono puntualmente respinte. Deduco, quindi, che non godano di ampio spessore le UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners che ritengono illegali l’utilizzo di manette per un periodo prolungato (a Ketsiot, questo avviene talvolta per giorni e giorni, bloccando mani e piedi) o il ricorso a celle di isolamento (le celle di Ketsiot sono della grandezza di 3 metri quadrati e ospitano una media di 5/6 detenuti per una decina di giorni).
Con la guerra del Golfo, si inaspriscono le condizioni di vita. Con l’insistenza delle pressioni internazionali, il numero dei detenuti cala. Ma il loro stato peggiora. Così, il campo carcerario istituito dal governo Rabin a seguito della prima intifada – per raccogliere 5000 tra lanciatori di pietre, attivisti e leader, ossia l’intellighenzia palestinese, secondo un disegno che indebolisse e contrastasse l’intifada stessa – e che, una volta superata la situazione d’emergenza, avrebbe dovuto essere smantellato, non ha esaurito la sua funzione. Anzi.
Nel 2002, i detenuti protestano denunciando l’assenza di acqua calda e di elettricità costante, il sovraffollamento e il divieto di visite da parte dei familiari. Gli scontri portano a 16 feriti: 14 tra i detenuti, 2 tra le forze dell’ordine. Nel 2003, si avvia un progetto per raddoppiare la capacità di Ketsiot così da rendere il campo capace di accogliere 12·000 detenuti, rispondendo alla politica di arresti su larga scala, per i quali si portano in carcere 15 palestinesi ogni giorno.
2012 – Viene approvato un ulteriore progetto per rendere Ketsiot atto a contenere 16·000 detenuti. Ma c’è una novità: la maggior parte dei detenuti è rappresentata da immigrati, principalmente originari di Eritrea e Sudan, arrivati per richiedere asilo allo stato di Israele, il quale né esamina le loro richieste, né concede loro alcun diritto, proteggendoli unicamente dalla deportazione. La prassi è quella di incarcerare gli immigrati per un periodo minimo di tre anni, prolungabile ad libitum. Ciò implica, ad esempio, che a Ketsiot bambini nascano e crescano, senza conoscere il significato della parola fuori. Ad esempio.
Non hanno diritti, detenzione eterna per tutti. [..] A meno che non si possa deportarli, non resta altro da fare che incarcerarli e rendere le loro vite miserabili.
Il ruolo di legali e giudici si limita a informare i detenuti dell’impossibilità di modificare la loro situazione, i quali devono, dunque, accettare la loro situazione. Il titolo di un articolo mi sembra particolarmente efficacie per sintetizzare questo quadro: “Una prigione per richiedenti asilo nel deserto cocente, senza via d’uscita”. No way out.
Alcuni aspetti, dunque, permangono: le condizioni di vita dei carcerati, siano essi palestinesi o sudanesi o eritrei, si pongono ad un livello infimo e la carcerazione avviene senza processo e/o senza accusa. Inoltre, ieri come oggi, il carcere non ha alcun risultato deterrente nei confronti della rivoluzione prima, dell’immigrazione poi; non ha, quindi, un riscontro effettivo a livello di sicurezza interna. Il ruolo primario degli arresti, della detenzione a vita, delle condizioni umilianti, è unicamente di “saziare l’opinione pubblica”. Ma davvero? Pazzesco.
Per chiudere il parallelismo tra queste due condizioni, mi sembra illuminante la riflessione di Joseph Carens:
La cittadinanza nell’occidente è oggi assimilabile ai privilegi feudali di un tempo, ossia uno status ereditario che aumenta le possibilità di sopravvivenza del singolo. Per coloro che non nascano con tale status è praticamente impossibile acquisirlo. Come per i privilegi feudali ereditari, questo risulta difficilmente giustificabile.





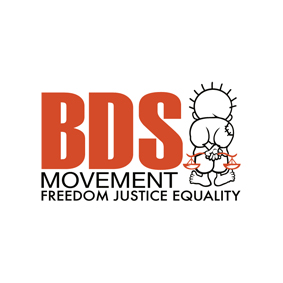


Commenti recenti