Posted: Febbraio 4th, 2014 | Author: Absa | Filed under: General, Recensioni | Tags: Ariel Sharon, Libro, occupazione, politically correct, Ramallah, Suad Amiry | Commenti disabilitati su Sharon e mia suocera
Nella casa alle fine di Nablus Road, una donna seduta al tavolo della cucina sbuccia una decina di arance per farne della marmellata; le mani lente, rugose lasciano scorrere il coltello sulla buccia porosa. Se non fosse per le tende di lino grezzo alle finestre, sarebbe travolta da una luce intensa. Tutto risulta, invece, soffuso ed ovattato. Solo i passi della nuora nella camera a fianco si fanno cautamente avanti nel silenzio della casa. Ma, anche in strada, non si sentono le voci dei bambini che vanno a scuola, né il traffico di Ramallah che poco a poco si risveglia. L’automobile nel cortile dei vicini assorbe il calore del primo mattino, eppure nessuno assapora questo tepore per le vie della città.
L’occupazione israeliana crea, quotidianamente, questo clima. Meno poetico, sicuramete; ma, per certo, irreale. Un tempo nuovo è scandito da una sospensione del coprifuoco e la successiva, in un calendario che veda come giorno zero l’inizio dell’assedio e che, da allora, ci frammenti in ore e minuti, perdendo la concezione di una più lunga durata. Ramallah potrebbe essere sostituita con una qualsiasi altra città della Cisgiordania. L’anno potrebbe essere il 1948 così come il 2002.
Mia suocera, che nel 1948 è fuggita a sua volta da Jaffa, mi dice: “Ciò che ho sperimentato qui, vicino alla Muqataa, nel settembre 2002, non è stato meno terribile di quanto ho vissuto a Jaffa nel 1948. Da quando sono arrivati è stato uno shawasher continuo, un disordine senza fine”.
Lo shawasher lo si vede nelle strade blindate, con le saracinesche dei negozi sempre abbassate, le macerie delle case, le macchine accartocciate. Lo si percepisce nelle cose e nelle persone che si è perse definitivamente, nella nostalgia violenta delle piccole abitudini abbandonate. Questo – cosa possa significare una vita sotto occupazione – è quanto ho capito leggendo Sharon e mia suocera, un centinaio di pagine scritte dalla palestinese docente e scrittrice Suad Amiry. Sebbene la struttura del libro sia quella diaristica, nella resa a tratti artificiosa, risulta discutibile l’impulso spontaneo e di sfogo-confessione che abbia portato alla scrittura del testo. Ma, ai fini della mia lettura, è stato un aspetto (forse) trascurabile. È chiara l’esigenza di scrivere per rintracciare una differenza tra i giorni. È chiara la volontà di denunciare l’assenza di una vita normale.
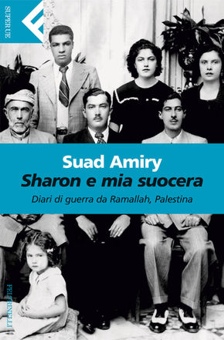
Le pagine di diario coprono un intervallo di tempo dal 17 novembre 2001 al 26 settembre 2002, data del ritiro definitivo dell’esercito israeliano dalla Muqataa, il quartiere di Arafat a Ramallah. In quel periodo Ariel Sharon è primo ministro dello stato d’Israele. Benché venga citato appena in un paio di occorrenze (“Sharon, stai risvegliando i nostri peggiori incubi”), è una presenza pervasiva in ogni pagina. È a lui, alla sua persona, che vengono ricondotte le azioni le cui conseguenze si ripercuotono sul microcosmo di Suad.
 Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile.
Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile.

Certo, con il politicamente corretto non si sbaglia mai. Nessuna accusa di essere partigiani, nessun rischio di fornire rivelazioni scomode né sconvolgenti. Ma il fatto che lo sia politicamente, non significa che lo sia per davvero, corretto.
 Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.
Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.
Insomma, non so come io avrei intitolato un articolo che riportasse la notizia della morte di Sharon. La percezione che ho avuto è, però, quella di un’estrema facilità nel ridurre un personaggio storico ai minimi termini, non curandosi della complessità storica e politica che questo abbia rivestito. Operazione pericolosissima, specie quando questa comporti una visione strettamente parziale e totalmente cieca alle antitesi. Mi sembra che, specialmente da morti, ad alcuni personaggi si riservi un atteggiamento buonista e perbenista, non capendo che il detto non si parla male degli assenti non significhi proprio questo.
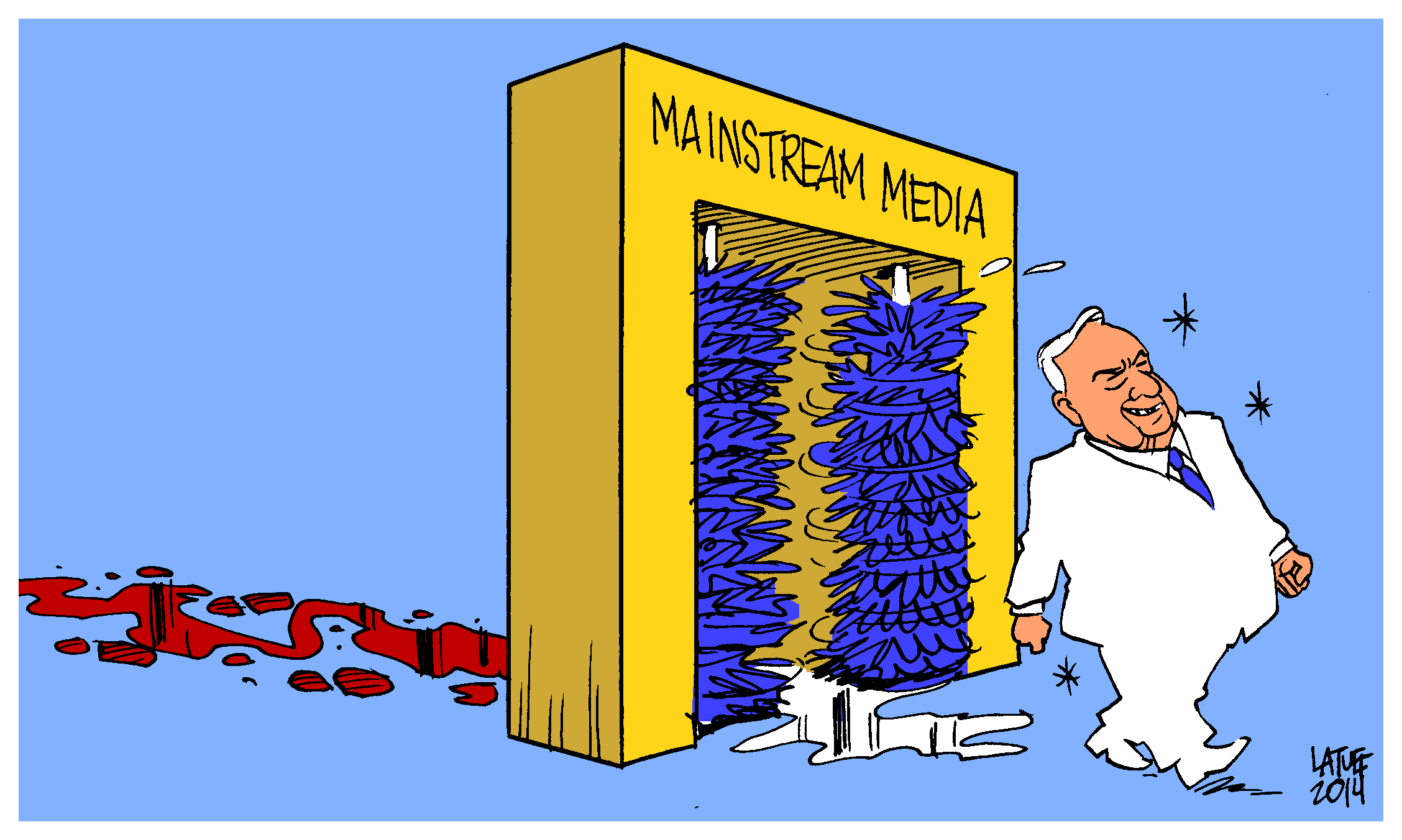
Posted: Novembre 25th, 2013 | Author: Neno | Filed under: General, Palestina per Principianti, Storia | Tags: 1948, 30novembre, guerra, nakba, palestina, profughi, storia orale | Commenti disabilitati su Nakba. Due storie, settecentomila storie
[Il terzo capitolo del nostro “compendio” di storia palestinese per principianti comincia a porre questioni di metodo. Se fino ad ora ci eravamo limitati a proporre qualche interpretazione sulle cause scatenanti del conflitto, ora ci troviamo davanti al momento in cui questo conflitto ha preso la forma odierna. E’ impossibile a questo punto sottrarsi ad un’esposizione “militante” dell’intreccio di vite che cambiarono irrimediabilmente a cavallo del 1948. Ma non possiamo nemmeno permetterci una narrazione personale compiuta di un momento tanto convulso. Per questo abbiamo deciso di giustapporre ad un brevissimo riassunto dello sviluppo complessivo dei fatti una seconda parte in cui ci limitiamo più che altro a rimandare alle raccolte di testimonianze palestinesi su quella che non smettono di chiamare nakba]

La storia scritta: la guerra del ’48. Alla fine degli anni Trenta, i tentativi inglesi di dividere la Palestina in due stati erano falliti (come ampiamente prevedibile). Lo stesso accadde con il tentativo di fermare l’immigrazione ebraica attraverso i tre Libri Bianchi, che si scontrarono con la realtà dell’aumento del flusso migratorio dovuto principalmente alle persecuzioni nazifasciste degli stessi anni. Il “conflitto a tre” si faceva sempre più acceso e diventava sempre più problematico per la Gran Bretagna alle prese con la guerra mondiale. Quando nel ’47 si giunse all’attentato del King David Hotel, gli inglesi rimisero il problema della spartizione all’ ONU e annunciarono il loro ritiro per l’anno seguente. La commissione UNSCOP, nata per l’occasione, s’impegnava a proporre un piano di spartizione che fungesse da compromesso, partendo dal presupposto che:
Era relativamente facile concludere, a quel punto [dopo le consultazioni informali], che, siccome entrambe le fazioni mantengono con decisione le loro richieste, è manifestamente impossibile in tali circostanze soddisfare completamente le suddette richieste, mentre è al tempo stesso indifendibile accettare incondizionatamente le richieste di una parte a spese dell’altra. (dal testo del Rapporto UNSCOP del 1947)
Il piano, approvato con la risoluzione 181 dalle Nazioni Unite, soddisfaceva tutti meno le parti in causa: la Gran Bretagna rimase fredda sottolineando le difficoltà pratiche, mentre da parte araba e da parte della destra ebraica venne un netto rifiuto. Quali che siano state le ragioni di tale rifiuto (il discorso è senz’altro complicato, e ci impegnamo a trattarlo in un altro post), quando il 15 maggio 1948 gli inglesi terminarono il “mandato” sulla regione, il conflitto era già iniziato. Alla vigilia della ritirata britannica veniva dichiarato e riconosciuto lo stato di Israele, il cui esercito si disfece dell’ esercito arabo di liberazione inviato dai paesi della Lega Araba. Qui tutto si ferma, e rimane il trauma, la nakba da una parte, “l’indipendenza” e la potenza dall’altra. Nel ’49 la guerra era finita: Israele aveva occupato il doppio dei territori stabiliti dalla risoluzione, la Palestina aveva visto settecentomila uomini e donne fuggire verso i paesi limitrofi. L’appropriazione della terra attraverso la cancellazione dei suoi abitanti.

Le storie orali. La nakba. Il verbo arabo nakaba significa “rendere infelice”, ma anche “deviare, scostarsi da (una via)”. Nakba non è una di quelle parole rese maiuscole da una Storia esterna, superiore e imparziale. Nakba porta in sé la presa di coscienza violenta e immediata di una svolta gigantesca e distruttiva, di un terremoto storico in cui si è perso tutto, un cambiamento immenso che però rende, appunto, infelici. “Catastrofe”, si traduce. Nakba è il titolo, forse anche il sunto, di decine di migliaia di racconti che narrano di villaggi abbandonati, di parenti morti, di battaglie perse, di fughe e di esilii forzati. Un trauma condiviso, perennemente minacciato di essere rimosso, di scomparire dietro espressioni neutre come “questione palestinese”, “guerra arabo-israeliana”, tra le tende dei campi profughi con la loro faticosa normalità o nella banalità sorridente dei vertici intergovernativi. In queste storie si intrecciano i ricordi pieni di nostalgia per i villaggi abbandonati, quelli d’infanzia di chi allora era un bambino, le memorie rabbiose di chi ha combattuto, in un mosaico collettivo che assume quasi sempre la forma di racconti orali e spontanei che passano attraverso generazioni diverse.

La parola nakba non deve necessariamente essere scritta per guadagnare forza. La memoria storica non è un lusso se sei nato in un campo profughi. Ma per evitare che queste narrazioni appassiscano, che si richiudano su se stesse, è importante conservare queste testimonianze, perché si possa continuare a ricucirle in un mosaico più grande, che vada oltre la Palestina verso tutte le altre lotte di resistenza. Linkiamo di seguito tre progetti on-line che si occupano di raccogliere e conservare testimonianze sulla Nakba:
– Nakba Archive, che raccoglie testimonianze molto varie, in arabo con sottotitoli in inglese.
– Al-Nakba Oral History Project, progetto aperto ancora in fase di sviluppo che conta molte testimonianze la maggior parte delle quali però è ancora senza traduzione.
– Nakba Survivor raccoglie invece video di testimonianze (in inglese) delle generazioni più giovani.
Raccomandiamo di sfuggita a tutt@ la partecipazione alla manifestazione nazionale del 30 novembre a Torino in risposta al vertice previsto per il 2 dicembre a Roma tra governo italiano e Palestinese, ma anche in solidarietà alle comunità minacciate dal Piano Prawer, oltre che alla comunità palestinese in generale. Noi ci saremo.
[Mentre riflettete: Ibrahim Maalouf – Diaspora]
Posted: Ottobre 21st, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: carcere, gaza, human rights watch, IDF, immigrazione, intifada, ketsiot, prigionieri palestinesi | Commenti disabilitati su Ketsiot, no way out
1993, 6 novembre – Il primo numero del settimanale Internazionale raccoglie nella sua magra cinquantina di pagine il “racconto di una giornalista israeliana sulla vita dei palestinesi nel peggiore campo di detenzione di Israele”. L’intifada in prigione di Ada Ushpiz, tre facciate nero su bianco, sei colonne in tutto, nessuna immagine – non che ve ne sia una stretta necessità: si tratta di uno di quei (meravigliosi) casi in cui le parole si srotolano nella nostra mente una dopo l’altra supplendo all’aspetto visivo, permettendoci di assistere alla scena narrata, fotogramma dopo fotogramma.
Ogni detenuto dorme su delle tavole di legno; la distanza fra le tavole che compongono il “letto” causa un forte dolore alla schiena. I materassi sono vecchi, maleodoranti. Le coperte sono piene di buchi e non esistono cuscini. Ogni tenda è illuminata con due lampadine da 25 watt, che non permettono la lettura notturna. I secchi della spazzatura sono scoperti, attirando zanzare e altri insetti. Nei bagni non c’è luce; ci sono insetti, serpenti, topi e scorpioni. I pasti sono sempre uguali, insufficienti per quantità e per qualità. I detenuti non sanno cosa gli è consentito per legge e quando chiedono miglioramenti nell’alimentazione gli viene risposto sempre che “questa è la legge”. Così nascono le malattie; spesso i detenuti devono protestare con lo sciopero della fame per ottenere di essere curati. A ciò si aggiungono sistemi disumani per far pressione sui malati, per fargli tradire il loro popolo e la loro patria. […] I bambini non possono toccare il padre o il fratello, il padre non può abbracciare i propri figli. In breve, le condizioni di vita nel carcere di Ketsiot non sono adatte agli esseri umani.
Si inserisca il tutto in un clima di umiliazione, violenza, divieto di visita da parte dei parenti, negazione del diritto di parola e di informazione. Ecco il campo di Ketsiot, situato nel deserto a sud di Gaza sul confine egiziano, nel 1993. L’articolo dimostra una (alquanto velata) speranza, riportando come in questo “periodo di nascita della pace” (si sono da poco conclusi gli accordi di Oslo) si sia aperto un dibattito, se non sullo smantellamento, almeno sul miglioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere. (Anche se qualche rigo dopo si manifesta un’evidente perplessità circa l’attuazione di queste misure.) Ma facciamo prima un passo indietro.

1991 – Che Ketsiot sia il peggiore campo di detenzione in Israele era già stato esposto dal rapporto di Eric Goldstein per Human Rights Watch: la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra, la quale proibisce il trasferimento delle persone incarcerate dai territori occupati ai territori del potere occupante. Inoltre, la pari distanza del sito da Gaza e dalla West Bank rende difficilmente raggiungibile l’area da parte di familiari e legali (ricordate il problema di muri e checkpoint vari e aggiungetevi la necessità di una richiesta scritta che i palestinesi devono presentare all’IDF per poter visitare i parenti in carcere). Ancora: Ketsiot è un deserto, con tutte le complicazioni atmosferiche che questo può avere (tempeste di sabbia, escursione termica da 0 gradi al caldo torrido, due o tre giorni senz’acqua), e i detenuti “vivono” in tende, le condizioni climatiche delle quali non possono essere attenuate. Il tono dell’intero rapporto si mantiene altamente oggettivo, al punto di essere quasi scambiato per cinico: è, quindi, proprio per questo significativo che arrivi ad affermare: “il campo di Ketsiot infligge ai suoi detenuti un regime di isolamento e violenza che va ben oltre l’essere semplicemente incarcerati”.
Leggendo che “la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra” ho (ingenuamente) pensato: “Finalmente qualcuno, impugnando questa Convenzione, farà qualcosa!”. Ma, dal momento che la Convenzione si pone “as conventional rather than customary law”, le sue disposizioni non possono essere fatte rispettare dalla corte israeliana, poiché non incorporate nella legge nazionale. Cioè: tutte le mozioni contro la legalità di Ketsiot vengono puntualmente respinte. Deduco, quindi, che non godano di ampio spessore le UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners che ritengono illegali l’utilizzo di manette per un periodo prolungato (a Ketsiot, questo avviene talvolta per giorni e giorni, bloccando mani e piedi) o il ricorso a celle di isolamento (le celle di Ketsiot sono della grandezza di 3 metri quadrati e ospitano una media di 5/6 detenuti per una decina di giorni).

Con la guerra del Golfo, si inaspriscono le condizioni di vita. Con l’insistenza delle pressioni internazionali, il numero dei detenuti cala. Ma il loro stato peggiora. Così, il campo carcerario istituito dal governo Rabin a seguito della prima intifada – per raccogliere 5000 tra lanciatori di pietre, attivisti e leader, ossia l’intellighenzia palestinese, secondo un disegno che indebolisse e contrastasse l’intifada stessa – e che, una volta superata la situazione d’emergenza, avrebbe dovuto essere smantellato, non ha esaurito la sua funzione. Anzi.
Nel 2002, i detenuti protestano denunciando l’assenza di acqua calda e di elettricità costante, il sovraffollamento e il divieto di visite da parte dei familiari. Gli scontri portano a 16 feriti: 14 tra i detenuti, 2 tra le forze dell’ordine. Nel 2003, si avvia un progetto per raddoppiare la capacità di Ketsiot così da rendere il campo capace di accogliere 12·000 detenuti, rispondendo alla politica di arresti su larga scala, per i quali si portano in carcere 15 palestinesi ogni giorno.
2012 – Viene approvato un ulteriore progetto per rendere Ketsiot atto a contenere 16·000 detenuti. Ma c’è una novità: la maggior parte dei detenuti è rappresentata da immigrati, principalmente originari di Eritrea e Sudan, arrivati per richiedere asilo allo stato di Israele, il quale né esamina le loro richieste, né concede loro alcun diritto, proteggendoli unicamente dalla deportazione. La prassi è quella di incarcerare gli immigrati per un periodo minimo di tre anni, prolungabile ad libitum. Ciò implica, ad esempio, che a Ketsiot bambini nascano e crescano, senza conoscere il significato della parola fuori. Ad esempio.
Non hanno diritti, detenzione eterna per tutti. [..] A meno che non si possa deportarli, non resta altro da fare che incarcerarli e rendere le loro vite miserabili.
Il ruolo di legali e giudici si limita a informare i detenuti dell’impossibilità di modificare la loro situazione, i quali devono, dunque, accettare la loro situazione. Il titolo di un articolo mi sembra particolarmente efficacie per sintetizzare questo quadro: “Una prigione per richiedenti asilo nel deserto cocente, senza via d’uscita”. No way out.
Alcuni aspetti, dunque, permangono: le condizioni di vita dei carcerati, siano essi palestinesi o sudanesi o eritrei, si pongono ad un livello infimo e la carcerazione avviene senza processo e/o senza accusa. Inoltre, ieri come oggi, il carcere non ha alcun risultato deterrente nei confronti della rivoluzione prima, dell’immigrazione poi; non ha, quindi, un riscontro effettivo a livello di sicurezza interna. Il ruolo primario degli arresti, della detenzione a vita, delle condizioni umilianti, è unicamente di “saziare l’opinione pubblica”. Ma davvero? Pazzesco.
Per chiudere il parallelismo tra queste due condizioni, mi sembra illuminante la riflessione di Joseph Carens:
La cittadinanza nell’occidente è oggi assimilabile ai privilegi feudali di un tempo, ossia uno status ereditario che aumenta le possibilità di sopravvivenza del singolo. Per coloro che non nascano con tale status è praticamente impossibile acquisirlo. Come per i privilegi feudali ereditari, questo risulta difficilmente giustificabile.

Posted: Ottobre 12th, 2013 | Author: Neno | Filed under: General, Recensioni, Rifiuti Generici | Tags: antifa, colonialismo, fabei, fascismo, lotte sociali, orbene, orientalismo, palestina | Commenti disabilitati su Antifascismo e Palestina. Appunti per un dibattito
Nella lunga serie di precisazioni “teoriche” da fare, e a mo’ di postilla all’ultimo capitolo del nostro “compendio” di storia palestinese, è forse opportuno aggiungere un distinguo di carattere prettamente politico al nostro discorso. È comunemente dato per scontato che la vicinanza ai palestinesi nell’ambito della “questione meridionale” sia una costante di sinistra. Orbene, facendo zapping cibernetico potrebbe esservi capitato di imbattervi in pagine come questa (ne ho scelta una a caso). Se aveste pazienza e stomaco a sufficienza, potreste trovarne molte altre simili. E dunque sì, i fascisti si dichiarano filopalestinesi.

Stefano Fabei (dx) e, a sx, Benito Mussolini (il dubbio era legittimo)
Svastiche e mezzelune. L’origine della propaganda filopalestinese da parte nazifascista risale agli anni ’30, quando entrambi i paesi dell’Asse avevano allacciato contatti con molte forze nazionaliste arabe per finanziare una guerriglia contro la Gran Bretagna mandataria. Di questi rapporti l’unica ricostruzione storica, almeno italiana, pare essere quella di Stefano Fabei. Il fascio, la svastica e la mezzaluna (Mursia, 2002) rappresenta effettivamente il primo tentativo di una narrazione unitaria del sostegno dei nazifascisti al nazionalismo arabo, ma in una maniera talmente acritica e decontestualizzata da far pensare che l’autore abbia effettivamente voluto sostenere una lettura di destra non solo della situazione palestinese, ma dell’intero Islam (!). Ad esempio, riguardo al rapporto tra la Germania nazista e il sionismo, Fabei pare non considerare determinante l’effetto delle persecuzioni antisemite sull’immigrazione verso la Palestina, accennando di sfuggita ai piani per “liberarsi degli ebrei” facendoli espatriare verso il Medio Oriente, sottolineando anzi (con soddisfazione, si direbbe) come il regime di Hitler concedesse agli arabi di usare i bagni pubblici interdetti ai “giudei”. Ma il lato più inquietante del saggio è il peso dato a certe interpretazioni piuttosto imbarazzanti che tentano di dimostrare una presunta affinità tra la visione politica arabo-islamica (ma araba o islamica? Di quali movimenti? Di quali strati sociali? Parliamo, per l’epoca, di ottanta milioni di arabi e di circa trecento milioni di musulmani) e quella nazifascista. Proprio la vaghezza di questi riferimenti permette a Fabei di evitare pressoché ogni riferimento alle finalità politiche (piuttosto evidenti) di un discorso del genere. In questa storia, gli stessi paesi arabi rimangono in secondo piano, e si dà quasi fin da subito per scontata la “simpatia araba per le forze dell’Asse”.

Antifascismo e Palestina. Un’opera del genere può lasciare ad un livello superficiale l’analisi dei rapporti storici tra fascismi e indipendentismo palestinese, ma mostra certo piuttosto bene l’atteggiamento odierno delle destre nei confronti della Palestina. La narrazione fascista della Palestina riprende quella tipicamente nazionalista del popolo che lotta contro l’invasore straniero per l’indipendenza. Il popolo è ovviamente considerato un blocco omogeneo non meglio determinato, che si immagina tenuto insieme da un impasto religioso-culturale costruito per l’occasione. Ma questo discorso tagliante e semplificante è già quello di chi guarda da fuori ma soprattutto da una posizione dominante. E’ l’orientalismo di cui fa un’ampia critica Edward Said, lo stesso che si fondava sul colonialismo europeo (e in cui a sua volta il colonialismo trovava una solida base). Si può scrivere una storia che riguardi i rapporti tra fascismi e paesi arabi senza che l’analisi passi per questi ultimi solo se si considera puramente teorico l’approccio da tenere verso le realtà extraeuropee (o extraoccidentali). Gli zoologi possono scrivere libri e libri per interpretare il comportamento di un animale, ma nessuno si sogna di chiedere all’animale stesso di intervenire nella loro stesura. E non si tratta affatto di un frame marginale o minoritario: è anzi la via retorica principale per ammantare di umanitarismo idee razziste o colonialiste, per sfociare spesso nel terrificante “aiutiamoli a casa loro” (“nutriamoli nelle loro gabbie” dice lo zoologo pieno di amore per gli animali che studia).
Come evitarlo? Non è una questione semplice. Forse fondamentale è cercare di non perdere di vista l’universalità della questione mediorientale. La lotta dei palestinesi contro lo sfruttamento, l’occupazione della terra e dell’acqua, la militarizzazione, l’opportunismo internazionale è la stessa lotta che combattiamo (dovremmo combattere?) anche qui. E non in senso metaforico. Si tratta di opporsi ad un sistema politico-economico che è lo stesso tra i checkpoint in Cisgiordania e nel cantiere della TAV, nell’apartheid arabo in Israele e nella schiavitù dei braccianti di Rosarno (e si potrebbe andare avanti, ovviamente). L’ideologia imperialista dei fascisti e della destra israeliana non è per nulla distante da quella dei “nostri” governi “occidentali”, che poi sono direttamente coinvolti nel sostegno alla colonizzazione della Palestina. Solo in quest’ottica la storia, le storie palestinesi possono diventare anche simboliche, e aiutarci a capire la nostra stessa realtà. Raccontarle senza perdere di vista la loro specificità e la loro complessità è quello che ci proponiamo fare.

Posted: Ottobre 4th, 2013 | Author: Neno | Filed under: General, Palestina per Principianti, Storia | Tags: anni trenta, colonialismo, haganah, irgun, mandato britannico, palestina, peel, spartizione, storia | Commenti disabilitati su Palestina negli anni Trenta. Dramma a tre voci.

Personaggi: Commissione Peel, arabi, ebrei, inglesi (nazisti, da qualche parte). Trama, conflitto a tre parti: gli arabi palestinesi combattono gli ebrei sionisti in cui vedono uno strumento degli inglesi colonialisti che combattono a loro volta; gli ebrei sionisti combattono gli inglesi colonialisti in cui vedono uno strumento degli arabi nazionalisti che combattono a loro volta; gli inglesi colonialisti reprimono tutto, ma si accorgono di non poterlo fare per sempre.
Anno domini: 1937, 1315 ca. dopo l’Egira musulmana. E’ nel periodo tra le due guerre mondiali che si trovano le radici più profonde del conflitto per la Palestina. Un conflitto annunciato (e ignorato), poi, una volta esploso, scomodo e spinoso per gli stati occidentali, inatteso e tragico per il medio oriente. Nel momento in cui assumeva il mandato sulla Palestina e dava appoggio alle richieste sioniste con la dichiarazione Balfour, la Gran Bretagna si trovava davanti una regione relativamente stabile e prospera, ma attraversata da profonde contraddizioni. I coloni sionisti erano circa trecentomila, e sarebbero andati aumentando dopo il ’33 per le persecuzioni nazifasciste (fatto che tra l’altro non impedì a Hitler e Mussolini di appoggiare alcuni movimenti nazionalisti arabi in funzione antiebraica e antbritannica). In breve tempo si erano appropriati (spesso comprandoli a pochissimo) di terreni sempre più estesi e decisamente fertili (e la terra fertile in Palestina non è infinita). Questa non sarebbe stata una novità nel mondo arabo, non fosse che i nuovi coloni parevano nettamente intenzionati a formare uno stato su quelle terre. Gli inglesi speravano comunque di riuscire a mantenere la stabilità (e il loro dominio coloniale).
Queste speranze furono alla prova dei fatti infondate poichè, nonostante la Palestina nel suo complesso fosse diventate più prospera, le cause delle rivolte del 1920 e ’21, segnatamente la richiesta da parte degli arabi di indipendenza nazionale e la loro opposizione al Focolare Nazionale [ebraico], sono rimaste immodificate e addirittura si sono accentuate per l’azione di “fattori esterni”, segnatamente la pressione degli Ebrei dell’Europa sulla Palestina, e lo sviluppo del nazionalismo arabo nei Paesi circostanti. (Dal testo del Rapporto presentato dalla Commissione Peel alle Nazioni Unite, come le citazioni seguenti; trad. mia)

La Commissione Peel (dal nome del funzionario britannico che la presiedeva) era stata creata per cercare una soluzione definitiva al conflitto, che dal 1935 aveva assunto proporzioni considerevoli con la “Grande Rivolta” araba, repressa violentemente dall’esercito inglese e resa ancor più sanguinosa dall’intervento delle milizie sioniste (Haganah e Irgun). Le svariate migliaia di vittime della repressione non potevano che rendere ancora più incandescente la situazione, posto che le stesse forze ebraiche si mostravano insofferenti alla presenza inglese. La Commissione inquadrava la situazione in una chiave semplice e netta: gli opposti nazionalismi arabo ed ebraico certo non lasciavano molte speranze alla Gran Bretagna di mantenere il controllo coloniale, ma parevano anche impedire qualsiasi forma di convivenza tra le altre due parti in gioco.
Il carattere del Focolare Ebraico è fortemente nazionalista. Non è nemmeno in questione la fusione o l’assimilazione tra le culture di Ebrei e Arabi. Il Focolare Nazionale non potrà essere semi-nazionale […] Il nazionalismo arabo è tanto intenso quanto quello ebraico. La richiesta dei leader arabi di autogoverno nazionale e di abbattimento del Focolare Nazionale Ebraico sono rimaste identiche al 1929.

D’altra parte era difficile che gli inglesi premessero troppo per una “assimilazione” che avrebbe rischiato di rivoltargli contro l’intera popolazione della regione su un unico fronte (per quanto quest’ipotesi fosse remota). Ma il divide et impera è un gioco pericoloso, specie quando le due parti divise hanno motivi uguali ed opposti per volerti distruggere prima di annientarsi tra loro. La Commissione Peel capì per prima che l’unico modo di salvaguardare la propria influenza, anche solo indiretta, era di dividere geopoliticamente l’area.
In queste circostanze la pace può essere mantenuta in Palestina sotto il Mandato [coloniale britannico] solo attraverso la repressione. Ciò implica il mantenimento di servizi di sicurezza ad un costo così alto che gli altri servizi, diretti “al benessere e allo sviluppo” della popolazione non potrebbero essere incrementati e anzi dovrebbero venire tagliati. […] L’idea della Partizione è stata senza dubbio pensata in un primo tempo come soluzione del problema, ma è stata probabilmente scartata perchè ritenuta impraticabile. Le difficoltà sono certo molto grandi, ma quando siano considerate da vicino, non paiono così insormontabili […] La Partizione offre possibilità di pace definitiva. Nessun altro piano lo fa.

Infatti il piano fu rifiutato dagli arabi insieme alla “pace definitiva” britannica, che suonava certo minacciosa. Nuove sollevazioni arabe avrebbero costretto gli inglesi a limitare l’immigrazione ebraica (con i tre Libri Bianchi), portando già durante e subito dopo il secondo conflitto mondiale, ad un esplosione del terrorismo sionista.
Posted: Settembre 29th, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: Checkpoint, documentario, Gerusalemme, IDF, Machsom Watch, muro, palestina | Commenti disabilitati su Good Times, bei tempi! (?)
[Soundtrack]
Abbiamo già parlato di muro e checkpoint, considerando sinteticamente il processo storico che ha portato alla situazione di attuale separazione in Palestina. Il documentario Good Times, bei tempi! – dalla regia di Alessandro Cassigoli e Dalia Castel (2004) – aiuta da un lato a particolarizzare questo argomento sul caso specifico del villaggio palestinese di Abu Dis, dall’altro a traslarlo da una prospettiva storica a una più umana e personale.

Il documentario è brevissimo: in circa trenta minuti raccoglie, attraverso immagini ed interviste, un quadro efficace del villaggio di Abu Dis, il quale, con la costruzione del muro di separazione nel 2002 finalizzato a bloccare gli attentati terroristici palestinesi, si è ritrovato spezzato a metà. Metà del villaggio è stata annessa a Gerusalemme, divenendo parte integrante del territorio israeliano; eppure parte dei palestinesi ha deciso di continuare a vivere e lavorare qui.
Mi limito solo a qualche osservazione.
Il soggetto – Abu Dis non è da considerarsi un unicum, bensì uno degli innumerevoli casi in cui il muro di separazione, assecondando una logica sensata solo dal punto di vista israeliano, separa i contadini dalle proprie terre, taglia a metà strade e villaggi, isola ed esclude. Quanti siano oggi i vari Abu Dis, io non saprei dirlo. Mi spaventa pensare, però, in quanti villaggi un ragazzo affermi “io non voglio né permessi, né carta d’identità israeliana. Niente. Voglio andare in America. Non voglio niente di tutto questo”, con il sorriso amaro di chi ha abbandonato la speranza.
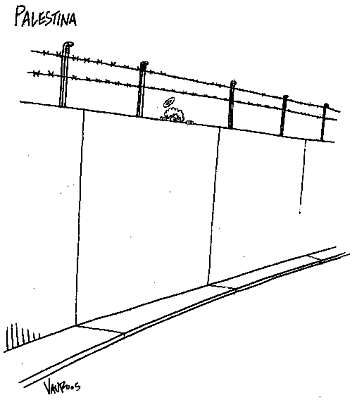
Il titolo – In un primo momento il villaggio di Abu Dis è attraversato da un muro “facilmente” oltrepassabile: i bambini passano attraverso le lastre di cemento, le signore anziane faticano a scavalcarlo, specie se cariche di borse della spesa. I soldati israeliani osservano, non intervengono mai, non controllano i permessi. “Se possono passare, perché li fanno scavalcare? Perché non renderla una cosa più umana?”. A volte i soldati non sono nemmeno presenti: “È ridicolo: se il pericolo fosse reale, dovrebbero essere qui 24 ore al giorno”. In seguito, questa misura permissiva è sostituita da un muro di otto metri di cemento armato, così che i palestinesi non avranno più alcuna possibilità di movimento, “non potranno più vedere le stelle”. Allora, quelli appena trascorsi, saranno bei tempi.

I personaggi – Tra i vari intervistati, nel documentario appare anche una donna appartenente al movimento Machsom Watch: inizialmente l’organizzazione di sole donne israeliane si è proposta, fra le varie attività, di monitorare il trattamento cui i palestinesi sono sottoposti ai checkpoint. “Iniziammo con l’osservare e poi capimmo che non potevamo stare solo a guardare e così abbiamo provato a dare una mano”. Le donne si battono per rivendicare il diritto dei palestinesi a muoversi liberamente sul loro territorio, come dichiarato dal manifesto del movimento. Documentano quanto accade, in un contesto di profonda sfiducia nei confronti dell’esercito israeliano, definito come “un bambino con una responsabilità troppo grande”. Si autodefiniscono le hostess dello stato di Israele, una sorta di Virgilio nell’inferno della quotidianità palestinese. Alla fine della cantica, però, non riusciranno “a riveder le stelle”, dal momento che otto metri di cemento sbarreranno loro la vista.
A.

Posted: Agosto 30th, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: acqua, colonie, insediamenti, Operazione Colomba, West Bank | Commenti disabilitati su Ordinaria amministrazione
[Soundtrack]
Scrivo a proposito di un’attualità così prossima da potersi ad essa riferire con le indicazioni temporali di ieri, settimana scorsa e simili. Non voglio fare informazione: non ne ho né i mezzi, né le capacità, né l’intenzione. Dopo che abbiamo provato a trattare, fra gli altri argomenti, di sionismo, di muro e check point, di terra e di acqua, provo a rispondere ad una domanda: “Cosa può accadere in un giorno qualunque, nella quotidianità del trovarsi a vivere in Palestina?”.
Questo giorno qualunque è domenica 18 agosto 2013. Vi svegliate con il sole che irrompe con violenza nella vostra camera: a poco servono le persiane sbarrate. Al vostro fianco, il letto è vuoto. Dalla cucina, vi raggiunge un profumo dolce e il passo leggero di vostra moglie. Sorridete. Tenete gli occhi ancora chiusi, assaporando quest’istante e ripassando velocemente il programma della giornata. È il caldo che vi convince definitivamente ad alzarvi. Nella bocca ancora impastata dal sonno, si mischiano il sapore del caffè e quello dell’uva. Dallo specchio del bagno, i vostri occhi reclamano ancora un po’ di riposo. Indossate una camicia pulita e i pantaloni migliori, vi sistemate i capelli e la barba da sempre minuziosamente curata: tenete a fare una buona impressione. Salite in macchina, aggiustate lo specchietto, vi dirigete verso la strada che porta dal vostro villaggio, Bir al Idd, a quello vicino ma..
Alcuni coloni israeliani hanno avvelenato un pozzo nel villaggio palestinese di Bir al Idd e per due volte hanno bloccato l’unica via d’accesso al villaggio, rimasta completamente bloccata per più di sei ore. [..] Né gli ufficiali della DCO (District Control Office) né i soldati hanno tentato in alcun modo di fermare i coloni. [..] Il villaggio di Bir al Idd è situato all’ingresso dell’area di Masafer Yatta, i cui abitanti subiscono continue minacce di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. Difatti, in questa zona il governo israeliano ha dichiarato la “Firing Zone 918”, ovvero un’area d’esercitazione militare permanente. I palestinesi che vi abitano sono in attesa della sentenza definitiva dell’Alta Corte israeliana che si pronuncerà sulla legittimità della zona militare. Nel mentre, le restrizioni alla libertà di movimento per gli abitanti persistono.
[Dal comunicato stampa di Operazione Colomba del 19 agosto 2013]
Potrebbe essere un episodio isolato, pensate. Un giorno particolare, in cui accada un’eccezione.

Il pozzo avvelenato presso il villaggio di Bir al Idd.
Mese di luglio, mese di Ramadan. Da questo Ramadan palestinesi e volontari si aspettavano un po’ di calma, un po’ di pace. Eppure la tregua tanto auspicata è stata raramente rispettata da coloni e soldati. E col Ramadan è venuta la voglia di riconquistare terre e valli di solito meno frequentate. Se ne sono accorti, in particolare, i coloni di un avamposto non molto distante da Tuwani, che da settimane ormai non danno pace ai ragazzi di Al Mufaqarah. Praticamente tutti i pomeriggi le greggi ricoprono la valle adiacente all’avamposto e praticamente tutti i pomeriggi soldati o coloni, imperterriti, vengono a scacciarli. A volte in modo piuttosto pacifico, a volte minacciando pastori e volontari. E il ritornello dei bambini – molti dei quali digiunano nonostante la giovane età – è sempre lo stesso: Ana ‘atshan!, ho sete.
Questo mese di luglio è stato anche il mese del rinvio dell’udienza che doveva decidere delle sorti del migliaio di abitanti della zona. Il governo israeliano vuol far credere che non si tratta di un’area permanentemente abitata, affinché possa esser dichiarata zona militare chiusa (per saperne di più, visitate il nostro sito www.nofiringzone918.org). Purtroppo, nemmeno quei quattro villaggi troppo vicini ad avamposti o colonie per esser dichiarati zona d’esercitazione militare (e quindi evacuati) sono del tutto esenti da ripercussioni. Se nelle colonie si costruisce senza freni, qui si consegnano nuovi ordini di demolizione.
[Dal report del mese di luglio 2013 redatto da Operazione Colomba]
Non un episodio isolato, dunque, bensì un continuo, assillante clima di intimidazione e di violenza. Negli anni questo clima è diventato costante, è diventato la quotidianità. Al punto di non fare più notizia. Al punto che, riportando questi episodi, sembra si corra il rischio di cadere nella banalità, nella retorica facile. Un pozzo avvelenato, un’aggressione ai pastori vengono relegati facilmente ai margini dell’attualità, al limite con il folklore. Nella logica dei grandi numeri, stare sei ore senza poter uscire dal proprio villaggio appare quasi insignificante. Nell’ottica della mala-informazione, leggiamo (forse) che una determinata area sarà o meno dichiarata zona militare chiusa ma non sappiamo cosa questo comporti, non sappiamo – paradossalmente – se ciò sia un bene o un male.
Oppure, un giorno qualsiasi potrebbe essere questo:
Per una volta, una bella notizia. Il mese di luglio, segnato dalle mille difficoltà e sempre più banali ingiustizie, è stato anche il palcoscenico di una commedia a lieto fine. La scena si svolge nella valle di Humra, a due passi da Tuwani. Protagonista è una famiglia di Al Mufaqarah. Il copione, per una volta, è davvero originale. Il sipario si apre su un pozzo, come ve ne sono tanti. Un pozzo la cui acqua non è avvelenata, il che, di per sé, è già una conquista. Un pozzo pieno d’acqua per una semplice ragione: si trova ad uno schiocco di dita o, sarebbe meglio dire, ad un tiro di pietra dall’avamposto di Havat Ma’on. Nei pressi di questo pozzo, in passato, è successo di tutto: attacchi dei coloni, persino una scritta che diceva a chiare lettere “Morte agli arabi”. E per passato si intende fino all’estate scorsa. I palestinesi avevano addirittura avuto l’onore di assistere a varie gite in piscina dei coloni: precisamente nel loro pozzo. Dall’inizio del mese di luglio, pazientemente e coraggiosamente, i genitori, N. e M., hanno deciso di riprendersi il pozzo. I loro figli vengono tutte le mattine al pascolo nella vicina valle di Kharrouba. Il padre o la madre, accompagnati dalla famiglia al completo, li raggiungono e tutti insieme appassionatamente se ne vanno al pozzo ad abbeverare le loro pecore. Una mattina, N. ha addirittura osato scendere la strada da Al Mufaqarah sul suo trattore e per tre volte riempire una cisterna d’acqua e riportarla al villaggio.
Una conquista, certo. Una vittoria.
Dal sapore agrodolce, perché, questa sì, non è che un episodio isolato.

Edifici in costruzione all’insediamento israeliano (illegale) di Elkana. [Ahmad Al-Bazz / ActiveStills]
Posted: Luglio 19th, 2013 | Author: Neno | Filed under: Palestina per Principianti, Storia | Tags: antisemitismo, balfour, palestina, sionismo, theodor herzl | Commenti disabilitati su Un po’ di preistoria. La nascita del sionismo
In principio era l’apartheid. La parola sarebbe nata solo nel 1917, proprio alla fine di questa storia, ma descrive perfettamente la storia degli ebrei in Europa. Storie di esclusione, di ghetti, ma anche di persecuzioni, di pogrom. Storie lunghe millenni. Quando il padre del sionismo moderno, Theodor Herzl, scrisse Lo stato ebraico (1896), il punto di partenza non poteva che essere questo:
Nessuno può negare la gravità della questione degli Ebrei. Dovunque vivano in numero percettibile, essi vengono più o meno perseguitati. […] Attacchi nei Parlamenti, nelle assemblee, sulla stampa, dal pulpito, sulla strada, in viaggio -ad esempio, l’esclusione da alcuni hotel- addirittura nei luoghi ricreativi diventano ogni giorno più numerosi. Le forme di persecuzione variano secondo i paesi e gli ambiti sociali nei quali avvengono. [traduzione mia]

A cavallo tra Otto e Novecento, l’Europa era ferventemente positivista, liberale, industrializzata. L’antisemitismo, la vergognosa propagine di medioevo che si trascinava persino nelle nazioni illuminate (basti pensare all’affaire Dreyfus), sembrava eliminabile (per quanto con ogni proabilità non rappresentasse un problema per i governanti di allora). Era il periodo d’oro dell’impero britannico, quello in cui una grossa parte dell’opinione pubblica si appellava alla missione civilizzatrice occidentale nel “terzo mondo”. Non è così strano che la soluzione (almeno teorica) venne trovata all’interno di ciò che più di tutto muoveva la politica, l’ideologia e le speranze dei grandi stati europei: il colonialismo. La civiltà si muoveva, o così pareva, al ritmo dei flussi di materie prime che arrivavano dall’Africa, delle ferrovie costruite in India. La nascita di un impero sembrava naturale, spontanea, giusta. Almeno nei salotti dell’Inghilterra vittoriana.

Questo clima culturale non poteva non influenzare gli intellettuali che diedero vita al sionismo. L’idea di Herzl riflette (in maniera senz’altro più ingenua) lo stesso ottimismo: le persecuzioni contro gli ebrei si sarebbero risolte con l’emigrazione di questi ultimi in una terra che sarebbe diventata lo stato ebraico:
L’intero piano è nella sua essenza perfettamente semplice, come dev’essere necessariamente se deve avvenire con la comprensione di tutti. Garantiteci la sovranità su una porzione del globo abbastanza grande da soddisfare i giusti requisiti di una nazione; al resto penseremo noi.
Le due “porzioni di globo” più quotate erano allora l’Argentina, meta di gran parte dell’emigrazione ebraica dell’epoca, e la Palestina, sentita come “la nostra patria storica dacchè abbiamo memoria” (sempre Herzl); a queste si aggiunse l’Uganda negli anni successivi. Fu l’Organizzazione Sionista creata dallo stesso Herzl a decretare, nel 1897, la scelta della Palestina: “Il sionismo persegue per il popolo ebraico una patria in Palestina pubblicamente riconosciuta e legalmente garantita”. C’è un notevole slancio idealistico in questa presa di posizione, c’è la volontà di costruire una nazione moderna basata sulle idee nuove ottocentesche: all’interno dell’Organizzazione si incontravano ferventi liberali (che facevano capo allo stesso Herzl) e socialisti (all’origine del movimento dei kibbutz). La convinzione condivisa era che il grado di sviluppo del nuovo stato avrebbe finito per mettere d’accordo tutte le altre nazioni coinvolte:
Se Sua Maestà il Sultano fosse dell’idea di concerderci la Palestina potremmo in cambio impegnarci a sistemare completamente la situazione finanziaria della Turchia. Lì potremmo far parte di un baluardo dell’Europa contro l’Asia, un avamposto della civilizzazione contro la barbarie.

Le popolazioni locali non vengono neppure menzionate, ma il giudizio implicito è chiaro: barbari. Ancora una volta: se a noi questa mentalità coloniale può sembrare ripugnante, non va dimenticato che all’epoca quella era la mentalità effettivamente dominante nella politica occidentale. In ogni caso l’Organizzazione Sionista continuò ad organizzare l’emigrazione. Alcuni insediamenti erano già nati, altri sarebbero stati costruiti di lì a poco, in seguito alle ondate migratorie del primo decennio del Novecento (soprattutto dalla Russia, teatro di violenti pogrom). Intanto l’Organizzazione cominciava a funzionare da vero organo politico degli ebrei in Europa: Herzl, eletto presidente, fece numerosi tentativi di ottenere l’appoggio dei governanti delle maggiori nazioni occidentali. Non avrebbe avuto successo, ma solo nell’immediato.

Nel 1917 il Ministro degli Esteri britannico, sir Arthur James Balfour, dichiarava con una nota ufficiale destinata a Lord Rothschild (uno dei personaggi di spicco del movimento sionista) che “Il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo”. L’importanza di questa dichiarazione è chiara se si considera che la Gran Bretagna si era già accordata con la Francia (accordi di Sykes-Picot, 1916) per ottenere un protettorato in Palestina. Sulle cause storiche della dichiarazione c’è gran confusione: si va da bizzarre storie secondo cui la dichiarazione fu ricompensa per l’invenzione di un nuovo tipo di esplosivo da parte di alcuni ebrei (!) a teorie decisamente più sobrie che mettono in luce la necessità da parte britannica di ingraziarsi i sionisti statunitensi in vista di un ingresso nella guerra mondiale. Ad ogni modo, con la Dichiarazione Balfour inizia la storia “moderna” della Palestina dilaniata: gli insediamenti ebraici avrebbero cominciato a crescere (soprattutto con le persecuzioni nazifasciste a partire dagli anni Trenta), ponendo definitivamente -agli arabi e agli ebrei, ma anche alle potenze occidentali- il problema della convivenza.
N.
Posted: Luglio 17th, 2013 | Author: Neno | Filed under: Documenti, General | Tags: fatah, gaza, gaza youth breaks out, hamas, palestina, sharek youth | Commenti disabilitati su Gaza Youth Breaks Out. Il secondo Manifesto
[Cito sempre (anche se sempre non è mai abbastanza) Stéphane Hessel e il suo Indignatevi (se non l’avete ancora letto, è tempo di farlo), nel quale l’autore esorta i lettori all’indignazione per la situazione odierna della Palestina. Ho sempre pensato che il destinatario di questo appello fosse l’occidentale medio, più o meno ignorante della questione. Leggendo il secondo manifesto di Gaza Youth Breaks Out, la prospettiva si ribalta, diventa una focalizzazione interna. L’indignazione dura e pura è quella dei palestinesi nei confronti dei palestinesi: il manifesto è una voce che denuncia la divisione e la corruzione tra le varie fazioni palestinesi, una voce che si articola nelle parole chiave di libertà, verità, unità. Poiché solo nell’unità risiede la forza dei Palestinesi, dal momento che Israele tenta ogni via per ottenere l’effetto contrario. Poiché solo verità e chiarezza sono i mezzi per ottenerla. Libertà poiché “vogliamo essere liberi. Vogliamo poter vivere una vita normale. Vogliamo pace”.]

Gaza Youth al pianeta Terra! C’è qualcuno lì fuori? “Gaza che??”
Il nostro primo Manifesto sembra aver causato qualcosa di più grande di quello che ci aspettavamo: molti ci hanno sostenuto, molti si sono posti nettamente contro di noi, e molto pochi sono rimasti indifferenti. Tutti avevano un’opinione, ma raramente ci si ascoltava, e in questa gran confusione la nostra voce è rimasta inascoltata.
Secolari, Islamofobi, Portatori di Divisione, Cospiratori, Immaginosi (?): siamo stati chiamati in tanti modi che abbiamo smesso di contarli e abbiamo cominciato a piangere. Sia i nostri sostenitori sia quelli che volevano abbatterci sembrano essersi fermati a UNA cosa del nostro manifesto: “Fanculo Israele. Fanculo Hamas. Fanculo Fatah. Fanculo ONU. Fanculo UNRWA. Fanculo USA!”. E non importa quello che abbiamo cercato di spiegare sulla nostra pagina Facebook, inutilmente.
Ma riguardo al resto? Chiariamo le cose, a partire dai movimenti palestinesi. Siamo stati duri, è vero. Eravamo arrabbiati, e lo siamo ancora. L’ordine in cui abbiamo elencato i ‘partiti’ non era volontario, e siamo consci che questo ha portato una certa confusione nelle menti della gente. In ogni caso, a coloro che ci accusano – per aver denunciato la corruzione dei nostri vertici politici – di aver insultato, oltre alle migliaia di persone che hanno votato Hamas nel 2006 (tra le quali noi), la memoria dei martiri appartenenti ai vari gruppi di Resistenza di fazioni diverse che hanno versato il loro sangue in varie occasioni, a partire dall’operazione Piombo Fuso, vogliamo rispondere chiedendo di non insultare il diritto del popolo palestinese di criticare i suoi politici.
Piombo Fuso non fu una guerra. Fu un massacro, una strage, tutto meno che una guerra. E durante questo massacro anche noi, abitanti di Gaza, abbiamo pagato con il nostro sangue. Ogni singolo palestinese ha sacrificato qualcosa, qualcuno, la guerra ha toccato tutti, dai più giovani ai più vecchi, non solo la Resistenza. Le bombe non fanno distinzioni. Non abbiamo mai inteso rifiutare la Resistenza, lo ripeteremo di nuovo; non rinnegheremo MAI quelli che lottano per noi, per la nostra Palestina, e certo questo NON era quello che abbiamo detto nel nostro precedente manifesto.
Si, abbiamo votato per il governo di Hamas. Lo abbiamo fatto tutti. Eravamo stanchi della corruzione di Fatah, volevamo un cambiamento e speravamo che Hamas sarebbe stato quel cambiamento. È PRECISAMENTE questo che ci dà diritto di urlargli contro la nostra rabbia, perché sono responsabili di noi, del nostro benessere e della nostra sicurezza. Nella West Bank Fatah arresta i membri di Hamas, a Gaza Hamas arresta i membri di Fatah, mentre ovunque in Palestina si possono trovare famiglie in cui i membri di fazioni diverse vivono uniti. Sì, denunciamo i politici – notate la parola: POLITICI – perchè il loro odio reciproco li ha divisi persino durante le commemorazioni del primo anniversario di Piombo Fuso, mentre una folla di palestinesi di tutte le fazioni è rimasta unita dal martirio, dalla pena e dall’amore per la Palestina.
Che voi vogliate o meno ammetterlo, che voi lo crediate o no, la corruzione esiste, ed è nostro diritto di palestinesi denunciarla, perché siamo stanchi. Il cambiamento interno non si basa soltanto su parametri interni. Il cambiamento arriverà solo se le persone fuori realizzeranno che è necessario tenere in considerazione il fatto che la corruzione esista, e che bisogna fermarla per tornare all’unità. E allora, se dobbiamo urlare al mondo per essere ascoltati dai nostri leader politici, perchè si occupino per noi di tenerci uniti, lo faremo migliaia di volte.
Non è di nessun aiuto chiederci di restare zitti davanti alle questioni politiche. Siamo accusati di incoraggiare la divisione perchè osiamo mettere in luce la debolezza dei nostri politici. Nessuno, tranne quelli che si trovano DENTRO, sa davvero come sia la vita in Palestina proprio a causa di queste divisioni. Tentare di metterci a tacere dicendo non criticate, mantenete le vostre divisioni ‘segrete’ e discrete è quanto di più dannoso! Semplicemente, conferma ai nostri politici che possono continuare a fare quello che fanno, che saranno supportati da persone che non conoscono la teoria che soggiace ai loro programmi politici. In altre parole, criticare i leader di Hamas – ma ALLO STESSO MODO i vertici delle altre fazioni – è un modo per noi di dire “se continuate in questa direzione, otterrete solamente divisione, che è quello che Israele vuole”. Dovremmo ricordare loro i nostri martiri e i nostri imprigionati, i nostri anziani, coloro che hanno fatto nascere e costruito questi movimenti. Dovremmo ricordare loro che Sheikh Yasin, Marwan Barghouti e tutti gli altri si meritano meglio di questo. Chi è nella miglior posizione per una simile onesta presa di posizione, se non i loro stessi figli?
Un’altra domanda è stata sollevata riguardo al nostro anonimato. Possiamo capirlo. Ciò che non capiamo è perchè, piuttosto che venire ascoltati nel nostro appello per la pazienza e il tempo, ci siamo visti presi immediatamente in una caccia alle streghe, tanto ridicola quanto affascinante per i deboli elementi usati per farci cadere. Un esempio?
“La base fondamentale di questo gruppo [Lo Sharek Youth Forum] è stata fondata dal National Endowment for Democracy degli USA (che ha fatto parecchio per rovesciare la democrazia in molti paesi). Allen Weinstein (uno dei fondatori del NED) ha dichiarato “molto di quello che noi del NED facciamo oggi era fatto sotterraneamente dalla CIA 25 anni fa”. Suona bene a qualcuno?”
Sul serio?! Perché avevamo accennato al fatto che la chiusura del forum – che era uno degli unici centri per i giovani rimasti a Gaza, uno degli unici posti dove i giovani potevano incontrarsi, imparare lingue straniere, usare internet, e godere di cose che non avevano a casa per sfuggire alla routine fatale di Gaza – sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per molti ragazzi che non avevano un altro posto dove andare, per questo la gente ha dato per assunto che la nostra “base” sia stata fondata dalla CIA? Altre persone sostengono sia più sospetto che il nostro manifesto abbia creato questo gran scalpore aprendosi ai giornali occidentali. Dov’è il ‘principio di presunzione di innocenza’? Pare che siamo le prime vittime del nostro successo.
Esistiamo, e se non vogliamo rivelare la nostra identità per ora – per ragioni di sicurezza – è un nostro diritto. In ogni caso, ulteriori prove della nostra esistenza giungeranno nei giorni successivi, alcune portate dai collaboratori di Electronic Intifada:
Asa Winstanley, Max Ajl e Jarid Malsin (giornalisti occidentali non mainstream e bloggers residenti a Gaza, dei quali mi fido personalmente) si dicono convinti che il manifesto sia autentico.
Qual è il nostro leitmotiv? Libertà. E, per questo, sappiamo che abbiamo bisogno che i palestinesi e i loro leaders politici si uniscano contro l’occupante sinoista. Ed è precisamente per questo che ci appelliamo all’azione. Ora. Non tra sei mesi, non tra un anno, non aspettiamo fino a che un altro massacro ci colpisca. Facciamo appello ai palestinesi perchè si uniscano e si organizzino in un efficiente movimento di protesta non violenta, di boicottaggio. Chiamiamo all’espropriazione e alle sanzioni contro “Israele”. Vogliamo di nuovo la nostra terra, il nostro diritto di muoverci, vogliamo poter scegliere di andare all’estero per avere una possibilità, come altre persone della nostra età, per avere un’educazione. Vogliamo poter commerciare liberamente con il mondo, avere un futuro ed essere motivati ad impegnarci per costruirlo. Ne abbiamo abbastanza di paura, terrore, miseria, sogni infranti, attacchi aerei, posti di blocco, lutti, violazioni di ogni singolo diritto umano che si suppone abbiamo.
Vogliamo tre cose. Vogliamo essere liberi. Vogliamo poter vivere una vita normale. Vogliamo pace. Chiediamo troppo? Siamo un movimento per la pace, formato da giovani di Gaza e dai loro sostenitori nel mondo, che non si fermeranno finchè la verità su Gaza non sarà conosciuta da ogni uomo sul globo in misura tale che non sarà accettato il tacito assenso, nè la rumorosa indifferenza nei confronti di quanto accade. E se dovessimo fallire, altri gruppi prenderanno il nostro posto, fino a che la nostra voce non possa essere ignorata oltre.
Posted: Luglio 3rd, 2013 | Author: Neno | Filed under: General | Tags: colonialismo, kerry, palestina, turismo, usa | Commenti disabilitati su Breve storia di un villaggio turistico
Sono un po’ stufo di scrivere articoli sul colonialismo israelo-statunitense in Palestina. Né dubito che voi siate stanchi di sorbirvi riflessioni pedanti sulla questione. Poi però uno legge che gli USA hanno stanziato quattro miliardi di dollari in investimenti privati per sviluppare l’economia palestinese. In particolare il turismo. Immensa gioia di grandi industriali di ambo le parti (Israele e Palestina, intendo). E allora forse non sono io che mi ripeto, è la storia (e la sua narrazione) che cambia ben poco. Perché questo stesso racconto lo abbiamo sentito un miliardo di volte. È il racconto di come un paese da terra occupata (o tiranneggiata) che era compie la metamorfosi che lo renderà – per sempre? – un villaggio turistico. Suona più o meno così:

Sempre le solite caricature
C’erano una volta un paese prospero e felice ed un paese sottosviluppato. Il re del paese prospero e felice ogni mattina si affacciava alla finestra, guardava la sua terra stendersi davanti a lui (ma in realtà guardava solo il parco della reggia, chè il paese prospero e felice era un moderno stato-nazione di grande estensione), e rientrava fiero di sè a leggere i giornali (ma in realtà leggeva solo qualche giornale), a partecipare a riunioni dell’Unione delle Nazioni Prospere e Felici (che poi unite non lo erano per niente) e a portare a cena sua moglie (la quale, a ben vedere, non lo amava per nulla). Il re del paese sottosviluppato, invece, era uno stronzo. Non si affacciava alla finestra per paura di ricevere una revolverata dai suoi sudditi. I quali sudditi erano piuttosto irritati non solo perchè lavoravano intere giornate sotto il sole in cambio di un paio di monete, ma anche perchè il paese prospero e felice confinante (che, guarda un po’, era proprio quello del re di prima) aveva sottratto loro circa due terzi del territorio, costruendo ovunque palazzi prosperi e felici. Insomma, non avevano più terra, cibo e acqua: il re del paese sottosviluppato aveva una gran voglia di abdicare e lasciare che prosperità e felicità conquistassero l’intero paese. I suoi sudditi non parevano d’accordo, e opponevano strane riflessioni su “libertà”, “autonomia”, “abbattimentodelleistituzioniborghesi” (questo solo alcuni).
La situazione divenne insostenibile. Tutti i politici dei paesi prosperi e felici visitavano il paese sottosviluppato per dargli sostegno nella sua agonia. La sera, nella reggia del re povero, s’incontravano con gli imprenditori per discutere sul futuro della piccola nazione. Era imprescindibile che il paese agonizzante diventasse, in questa o nella prossima vita, prospero e felice. I sudditi però resistevano. La questione divenne così importante che fu portata davanti all’Imperatore Sommamente Prospero di tutte le Nazioni Prospere. Quest’ultimo ascoltò il re felice ed il re infelice (o forse delegò questo compito a qualcun altro), pensò a lungo (ma forse rimase semplicemente zitto) e infine annunciò le sue conclusioni: “Potremmo varare un piano di aiuti da quattro miliardi di dobloni al paese povero. Così non ci sarà più bisogno che l’altro paese costruisca i palazzi, li costruirano loro stessi, proprio loro che tengono tanto all’indipendenza” (ma alcuni dicono che non parlò affatto).

L’Imperatore e i due re (si capisce quale sia quello prospero e felice)
Il piano fu varato, per la gioia dei grandi imprenditori (quelli dei due paesi ormai in pace e – soprattutto – quelli del paese dell’Imperatore). In breve tempo, il paese ormai-non-più-sottosviluppato fu pieno di palazzi. Il re povero poté finalmente affacciarsi alla finestra e vedere soltanto il parco della sua reggia. Finché un giorno un ambasciatore imperiale fece presente al re che il suo paese era indebitato con l’Imperatore di quattro miliardi di dobloni. Il re, a ben vedere, non ne aveva. Siccome però il paese non produceva nulla che interessasse allo stato imperiale ma aveva un paesaggio molto pittoresco, la soluzione fu presto trovata: si smantellarono le fabbriche, si requisirono le terre, e si cominciò a costruire un meraviglioso, immenso villaggio turistico. Ora i sudditi dell’Imperatore potevano rilassarsi all’ombra di un albero, sulle colline del paese che era stato sottosviluppato. I soldi che pagavano venivano usati per ripagare il debito. Misteriosamente, la piccola nazione non si arricchì mai. Il re, dal canto suo, stava piuttosto bene, e così i suoi imprenditori.
Poi, un giorno, il piccolo paese sparì. Alcuni dicono che fu conquistato da un altro paese, forse proprio quello dell’altro re (quello non amato dalla moglie), altri ancora dicono che semplicemente implose, così, per caso. Infine, alcuni folli affermano che non sia scomparso. Semplicemente, dicono, ne scomparve il re.
N.

Ma l’Egitto è dove c’è Sharm el-Sheikh?
 Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile.
Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile. Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.
Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.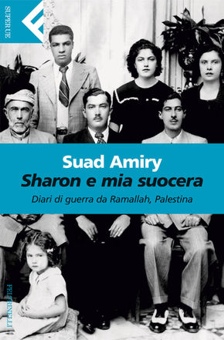

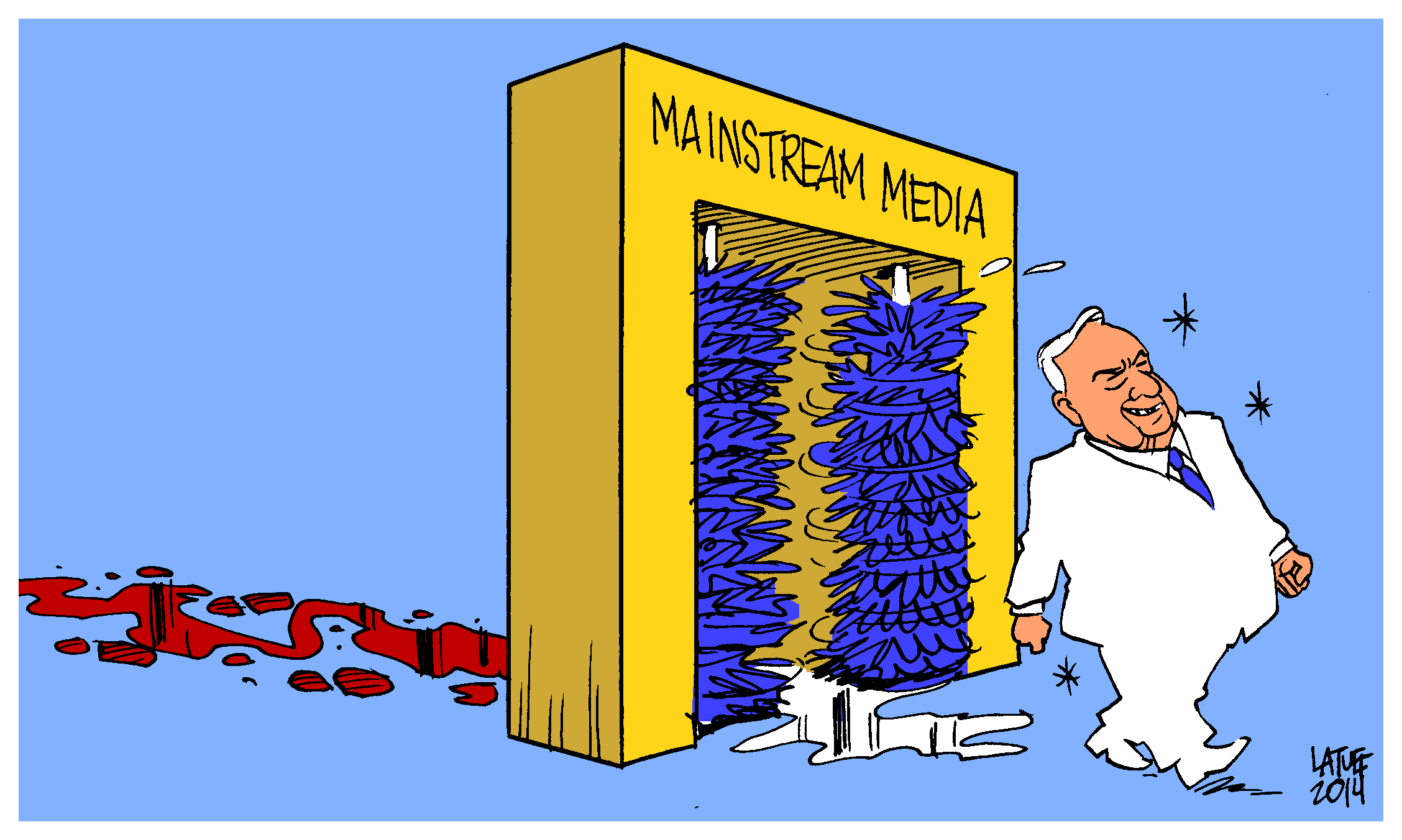














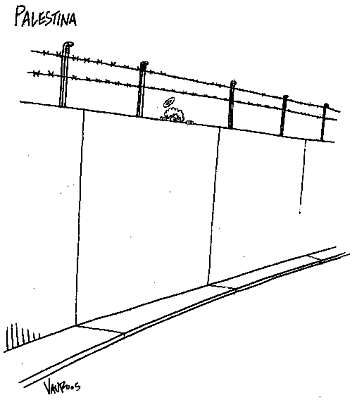













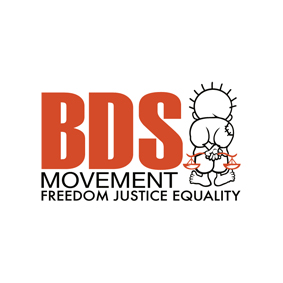


Commenti recenti